
A chi non fa paura l’idea della crescita esponenziale delle città dell’Asia o del cosiddetto “terzo mondo”, o l’idea apocalittica (anche se formulata da un punto di vista critico) di vivere in un pianeta degli slums? Eppure, nei luoghi in cui questo fenomeno si vive più da vicino – come nei quartieri popolari di Mumbai, India – l’idea di slum viene messa in dubbio da vari decenni. Parti della città che non meritano neanche il nome di quartieri, e che sono presentati sempre come caratterizzati da mancanze (d’igiene, di sicurezza, di integrazione, di controllo, addirittura di morale), ad uno sguardo più profondo rivelano storie e dinamiche complesse e funzionali, che sono state interpretate in forme molto diverse secondo le diverse scuole di pensiero. Dal loro ufficio nel quartiere di Dharavi-Koliwada (una zona resa famosa dal film Slumdog millionaire), gli attivisti urbani Matias ECHANOVE e Rahul SRIVASTAVA (del collettivo Urbz), da anni mostrano come una serie di strutture sociali spontanee, interne ai cosiddetti slums, generano un continuo miglioramento e sviluppo, spesso ostacolato dalle autorità locali o dai piani di riforma urbana. In territori densi e reticolari come boschi di mangrovie, gli unici strumenti di sviluppo valido sono quelli generati dagli stessi abitanti: homegrown, come i quartieri in cui vivono.
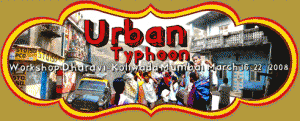 I laboratori Urban Typhoon [vedi PDF] sono momenti di incontro tra attivisti e studiosi, alcuni dei quali vivono nel quartiere, altri in altre città e continenti, per valutare come le risorse della popolazione possano essere strumenti per uno sviluppo autogestito. Non sono slum: sono villaggi, spiegano i due organizzatori nel loro affascinante blog airoots/eirut: Mumbai, città coloniale portoghese, è stata costruita su di un cluster di isole abitate da comunità di pescatori, una delle quali era il villaggio di Dharavi-Koliwada. Anche ora che è diventato uno dei quartieri più grandi dell’Asia, le sue stradine strette impediscono l’ingresso alle macchine e funzionano come multipurpose spaces, spazi dagli usi multipli definiti dai loro utenti; le case, più che baracche sono “Tool-houses” (non perdetevi questo video!) che crescono e si adattano col tempo alla gente che le abita; le migrazioni interne di massa hanno creato reti incrociati ed un sistema urbano complesso, che permette anche il miglioramento della vita nei villaggi d’origine. Lo stesso discorso sugli slum come spazi di assoluta miseria, e la sua versione cinematografica, diventano così profezie d’autocompimento, e ostacoli allo sviluppo di questi luoghi come homegrown cities, città autogenerate ed automantenute.
I laboratori Urban Typhoon [vedi PDF] sono momenti di incontro tra attivisti e studiosi, alcuni dei quali vivono nel quartiere, altri in altre città e continenti, per valutare come le risorse della popolazione possano essere strumenti per uno sviluppo autogestito. Non sono slum: sono villaggi, spiegano i due organizzatori nel loro affascinante blog airoots/eirut: Mumbai, città coloniale portoghese, è stata costruita su di un cluster di isole abitate da comunità di pescatori, una delle quali era il villaggio di Dharavi-Koliwada. Anche ora che è diventato uno dei quartieri più grandi dell’Asia, le sue stradine strette impediscono l’ingresso alle macchine e funzionano come multipurpose spaces, spazi dagli usi multipli definiti dai loro utenti; le case, più che baracche sono “Tool-houses” (non perdetevi questo video!) che crescono e si adattano col tempo alla gente che le abita; le migrazioni interne di massa hanno creato reti incrociati ed un sistema urbano complesso, che permette anche il miglioramento della vita nei villaggi d’origine. Lo stesso discorso sugli slum come spazi di assoluta miseria, e la sua versione cinematografica, diventano così profezie d’autocompimento, e ostacoli allo sviluppo di questi luoghi come homegrown cities, città autogenerate ed automantenute.
- Rahul SRIVASTAVA & Matias ECHANOVE (2012) “Reconocer la ciudad autogenerada” [traducción castellana en PDF][post original inglés en airoots.org]
- “Urbanistica collettiva: User-generated cities” (2012) Editorial sobre URBZ en italiano, publicado en Domus n.955 [PDF][enlace]
- Ananya ROY (2011) “Slumdog cities: Rethinking subaltern urbanism”, International Journal of Urban and Regional Research, vol.35.2 [PDF]
- Owen M. LYNCH (1979) “Potters, plotters, prodders in a Bombay slum: Marx and meaning or meaning vs. Marx”. Urban Anthropology n.8 [PDF parcial]
- Alpita MASURKAR (2011) “A Community between point A and point B: Mumbai local trains” ColabRadio, MIT [link]
- Sangharsh Nagar la ciudad de la lucha, post sul blog “El Antropólogo perplejo”